Che problema abbiamo con le aziende etiche?
Riflessioni sul complicato rapporto tra attivismo ed editoria trasparente
Il mondo del libro non è estraneo alle polemiche: da anni c’è persino una sorta di premio alla polemica più calda dell’anno, ideato da un profilo dedicato ai meme. I dibattiti più succosi tendono a trascendere l’ambito degli addetti ai lavori e dilagare sui social, presso un pubblico sempre affamato di litigi, passi falsi, bassezze. C’è poco da girarci intorno: la polemica fa notizia, muove i commenti, rinverdisce l’attenzione.
A volte una polemica porta anche a risposte concrete (come nel caso di quella gaffe di Giunti, redarguita dall’autore dell’opera originale per aver appiccicato sul testo tradotto una copertina realizzata con AI generativa, e con quell’aroma di whitewashing), a ricordarci che in un’economia capitalista la scelta di chi consuma può orientare il mercato verso soluzioni più o meno etiche.
Questo è vero per ogni industria, e l’editoria non fa eccezione. Molte persone utilizzano in modo consistente il proprio potere d’acquisto e d’immagine per portare avanti un dialogo su sviluppo sostenibile (per esempio acquistando solo libri usati), giustizia sociale (togliendo spazio ad autrici e autori che operano oppressione sistematica) e rappresentazione (promuovendo le voci di minoranze). Queste persone diventano dei punti di riferimento per il lettorato, e spesso si trovano a gestire infinite discussioni in privato per spiegare il proprio punto di vista, o per difendere la propria posizione. Non credo sia sbagliato considerare queste persone delle attiviste, anche se dubito si presenterebbero come tali.
Avendo avuto modo di conoscere da vicino la natura e le forme dell’attivismo del pubblico, quest’anno non ho potuto non rendermi conto di una realtà disorientante: le Bookblogger che fanno attivismo (mi si conceda il femminile sovraesteso, perchè si tratta per lo più di ragazze) detestano le imprese etiche.
Forse il termine “detestare” è un po’ forte per descrivere un sentimento che credo perlopiù inconscio, ma la semplice antipatia non giustificherebbe il desiderio un po’ morboso di screditare le aziende che vogliono lavorare bene, e magari guadagnare facendolo. Nota bene: anche l’operato della più etica delle case editrici non sarà mai del tutto esente da errori, e non è certo nostro compito prenderne le difese. Ma abbiamo perso il conto di quante volte qualcunə sia venuto a chiederci perché la tal CE non sia tra i firmatari della petizione contro Più Libri Più Liberi (risposta: perché la petizione è stata fatta girare durante il festival nel corso di una mattina, tra editori che già si conoscevano, e non divulgata altrove), o perchè quell’altra non abbia fermato la propria attività di vendita durante il Salone del Libro di Torino, mentre fuori erano in corso le manifestazioni pro-Palestina (risposta: perché le informazioni non circolavano all’interno del Lingotto, e la gran parte degli editori era del tutto ignara di ciò che stava accadendo fuori). Vi ho dato l’idea?
Il minimo comune denominatore di queste domande è il tono capzioso con cui sono poste, unito a un sottotesto accusatorio: se queste realtà editoriali sono così etiche e limpide come vogliono far credere, perchè non si sono esposte sulle questioni che io reputo importanti? Mettendo da parte il problema del valore (cioè assumendo che tutte le aziende etiche abbiano la medesima sensibilità sugli stessi temi), i due esempi di cui sopra dovrebbero mettere in luce un problema piuttosto ovvio: per scegliere è necessario avere accesso a informazioni di contesto e di contorno.
Molte persone sembrano incapaci di credere che un’impresa non sia in possesso delle informazioni che hanno in mano loro, perciò non estendono a esse il principio di buona fede. Ma è davvero così assurdo che il titolare di una casa editrice non sia a conoscenza di una polemica avvenuta nel Bookstagram anni prima che aprisse la sua impresa? O che la presenza costante al banchetto di vendita dei libri lə alieni a quello che sta succedendo a tre padiglioni distanza?
Che ad aziende che si presentano come etiche sia richiesta maggiore accountability è naturale: diamo per scontato che l’impresa etica guadagni attraverso la propria immagine, e desideriamo vegliare affinché non si trasformi in un’impresa di x-washing. Tendiamo a dimenticare, però, che lavorare in modo etico non è affatto più conveniente che non farlo (spoiler: altrimenti lo farebbero già tuttə); e il ritorno di immagine non necessariamente colma il divario economico tra le due opzioni. Chi guadagna di più, una CE che paga i propri autori, o una che trattiene i proventi con contratti di sfruttamento? Una che realizza le copertine con AI generativa, o un’altra che paga illustratore e grafico? Ho aperto questo articolo parlando del potere del consumo etico, ma quanto è diffusa questa consapevolezza tra chi acquista un libro? Quanta parte del lettorato è consapevole che quella casa editrice presente a tutti i festival non paga le royalties da anni? Quantə sono davvero in grado di distinguere una copertina realizzata da AI? A quante persone importa?
La mia impressione è che il sospetto verso le imprese etiche usi il principio dell’accountability per mascherare un desiderio meno sano, e purtroppo preponderante nella nostra società: quello di veder fallire chi fa bene. Proviamo una soddisfazione morbosa nel trascinare Miss Perfettina giù dal piedistallo, poco importa se sul piedistallo l’abbiamo messa noi. Questo accanimento, già inutile se assumiamo che alla guida di imprese etiche ci siano persone con un’etica (che avrebbero quindi meno bisogno di essere controllate a ogni passo), diventa controproducente se sottrae energie allo sviluppo di un’industria culturale etica. Il principio dell’accountability andrebbe innanzitutto esteso alle imprese che operano in modo non-etico, in modo da elevare il valore dell’intera filiera. Studiare l’operato delle aziende trasparenti dovrebbe consentirci di individuare e prendere provvedimenti contro chi opera secondo principi contrari, non definire la scala (soggettiva e parziale) di cosa non è abbastanza.
Scritture e novità
Qualche settimana fa abbiamo fatto un ritiro di scrittura nella splendida cornice del Castello di Cernusco Lombardone. È proprio vero che si conoscono meno i luoghi in cui si abita: questa meraviglia del XII secolo è stata una vera scoperta.
Con un’ambientazione così suggestiva e con del raro tempo a disposizione, abbiamo terminato di scalettare il secondo volume della trilogia.
Ora stiamo lavorando al terzo libro, in modo da sapere esattamente cosa succede in ogni capitolo. Una volta terminata questa fase (che è quella che ci impegna più a lungo), potremo finalmente metterci a scrivere… se non vediamo l’ora che sia quel momento, sapere che prima dobbiamo gestire il finale di una storia così complessa è un po’ terrificante. In ogni caso, contiamo di terminare la scaletta analitica entro l’anno, per affrontare la stesura a partire da gennaio.
E a proposito di gennaio…
Quando uscirà la prossima newsletter, avremo finalmente svelato il segreto che abbiamo così gelosamente custodito negli ultimi mesi (nonché la principale ragione della nostra lontananza dai social!). È un progetto ambizioso e comunitario - di più non possiamo dire.
Consigli di lettura
Dicembre è per noi il mese della saggistica. Il titolo più rilevante tra quelli che abbiamo affrontato nella nostra fase di documentazione pre-scrittura è “Il primo libro di etica ambientale” di Robin Attfield.
Il saggio è stato portato in Italia da Einaudi nel 2024, ma l’originale è stato pubblicato nel 2018. Una breve postfazione cerca di colmare la lacuna degli ultimi anni di dibattito filosofico, ma l’ottimismo del 2018 trova poco spazio nel mondo post-pandemia (e in cui le guerre hanno catalizzato attenzione e risorse a scapito della crisi climatica).
Al netto di un’ottimismo che oggi suona un po’ ingenuo, il saggio è un’interessante compendio per chi si avvicina per la prima volta al concetto di etica ambientale. In modo chiaro e conciso, Attfield analizza i concetti chiave di natura e valore, esaminando attraverso la filosofia i motivi etici (razionali ed emotivi) per cui chiunque dovrebbe agire per la salute dell’ecosistema. Particolarmente interessante la disamina dei principi per l’agire corretto tramiti e possibilità di realizzazione: consapevolezza morale, modello contrattuale, etica della virtù, regole e doveri.
Anche per questo mese è tutto. Buon nuovo inizio, e a risentirci!





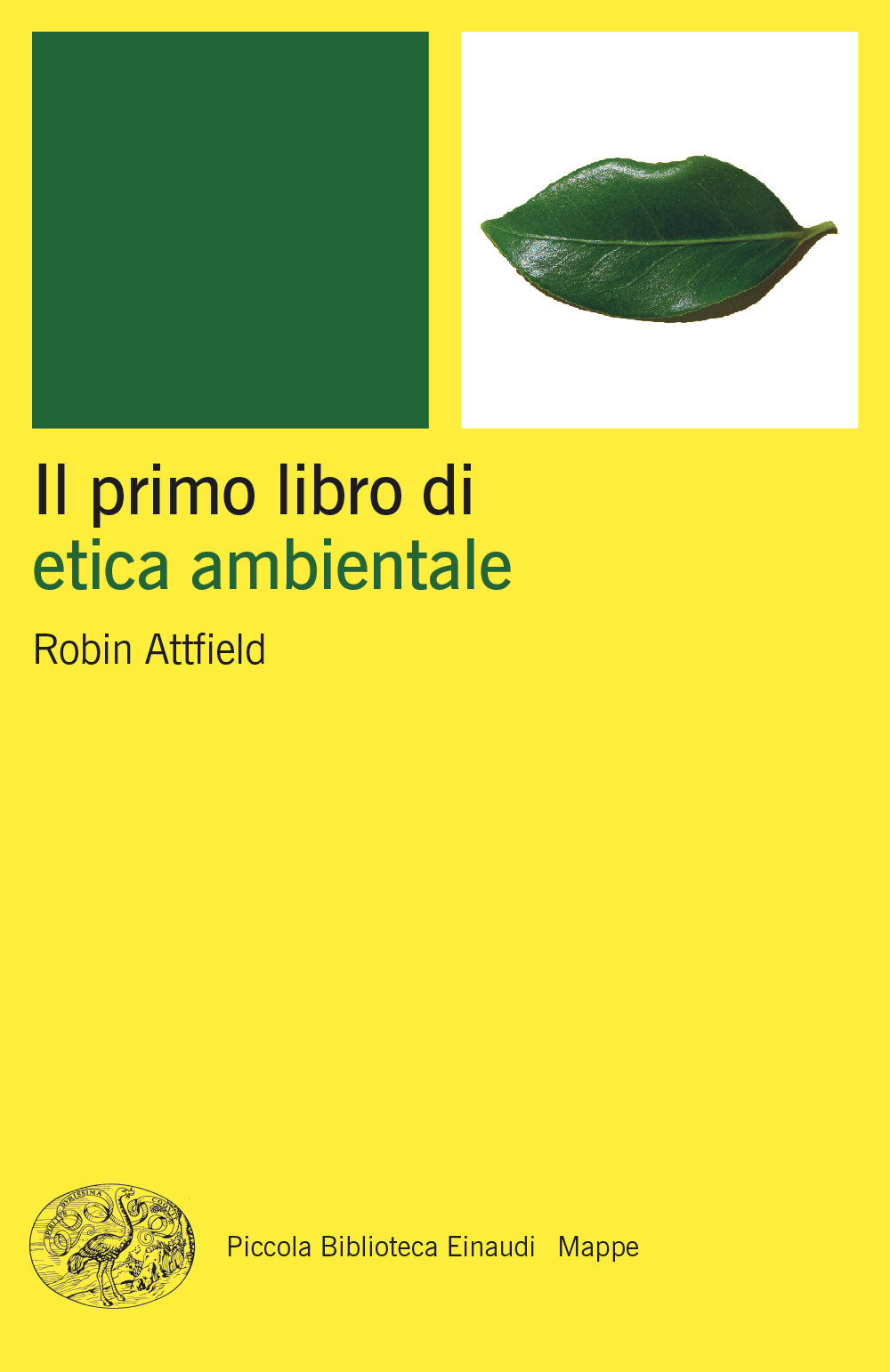
Premetto di essere un uomo cisgenere bisessuale e autistico, quindi mi scuso in anticipo se il commento seguente denotasse dell'androcentrismo.
La mia personalissima impressione è che fare le pulci e stracciare le vesti a chi non si dimostra persona progressista perfetta, nell'editoria e non solo, sia figlia di due dinamiche che al padronato patriarcale e capitalista fanno estremamente comodo:
- spingere l'attivismo via dall'azione tangibile sul territorio e restringerlo il più possibile alla divulgazione sui social network, che ovviamente appartengono alle elite e forzano la gente a giocare secondo le regole delle elite.
- spingere nella dinamica succitata soprattutto le attiviste donne, per impedire loro di sviluppare una riflessione e una pratica femminista solide confrontandosi con altre attiviste donne (e con eventuali attivisti uomini che non abbiano tuttora la cacca nel cervello), con il risultato di inficiare i loro sforzi grazie alla sopravvivenza di dinamiche sociali patriarcali introiettate – tipo la maldicenza reciproca e compiacente da comari di villaggio.
Mia personalissima conclusione: abbiamo tanto bisogno di ricominciare a "toccare l'erba" da un lato, e dall'altro lato di fuggire dall'internet delle corporazioni.